* di Cristina Di Silvio
La crisi della legalità internazionale, quindi del diritto, tra omissioni politiche, arresti extraterritoriali e l’urgenza di una nuova etica della responsabilità giuridica globale.
L’intervento della Società di Diritto Internazionale
Con un’affermazione tanto disinvolta quanto devastante, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha dichiarato in diretta televisiva: «Il diritto internazionale vale fino a un certo punto».
Una frase che, per il suo contenuto, non può essere archiviata come un mero scivolone comunicativo.
È una frattura. Un segnale di cedimento profondo, istituzionale, culturale e giuridico. Una frattura che spezza, dall’interno, l’equilibrio fragile su cui poggia la legalità internazionale, e che fa vibrare le fondamenta stesse dello Stato di diritto italiano.
La Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea (SIDI) ha reagito immediatamente, con una nota formale indirizzata al vertice dell’esecutivo e al Presidente della Repubblica, sottolineando l’inaccettabilità — costituzionale e politica — di un’affermazione che scredita non solo le regole che disciplinano i rapporti fra gli Stati, ma anche i diritti fondamentali che quelle regole tutelano. Eppure, è il silenzio — politico, mediatico, istituzionale — che segue a impressionare maggiormente. Silenzio che sa di assuefazione. Di resa.
L’affermazione di Tajani arriva in un momento in cui il diritto internazionale è sottoposto a pressioni mai viste dalla fine della Seconda guerra mondiale.
In Ucraina, da oltre tre anni, la resistenza all’aggressione russa si consuma nel sangue e tra crimini di guerra documentati.
A Gaza, intere comunità civili vivono sotto assedio permanente, tra bombardamenti indiscriminati, blocchi umanitari e punizioni collettive, mentre i principali organi delle Nazioni Unite e della giustizia internazionale emettono — quasi inascoltati — richiami, denunce, ammonimenti.
In questo contesto, delegittimare pubblicamente il diritto internazionale significa schierarsi, consapevolmente o meno, con chi di quel diritto fa scempio. È partecipare alla normalizzazione della violenza giuridicamente impunita. È legittimare l’arbitrio come strumento di governo delle relazioni internazionali.
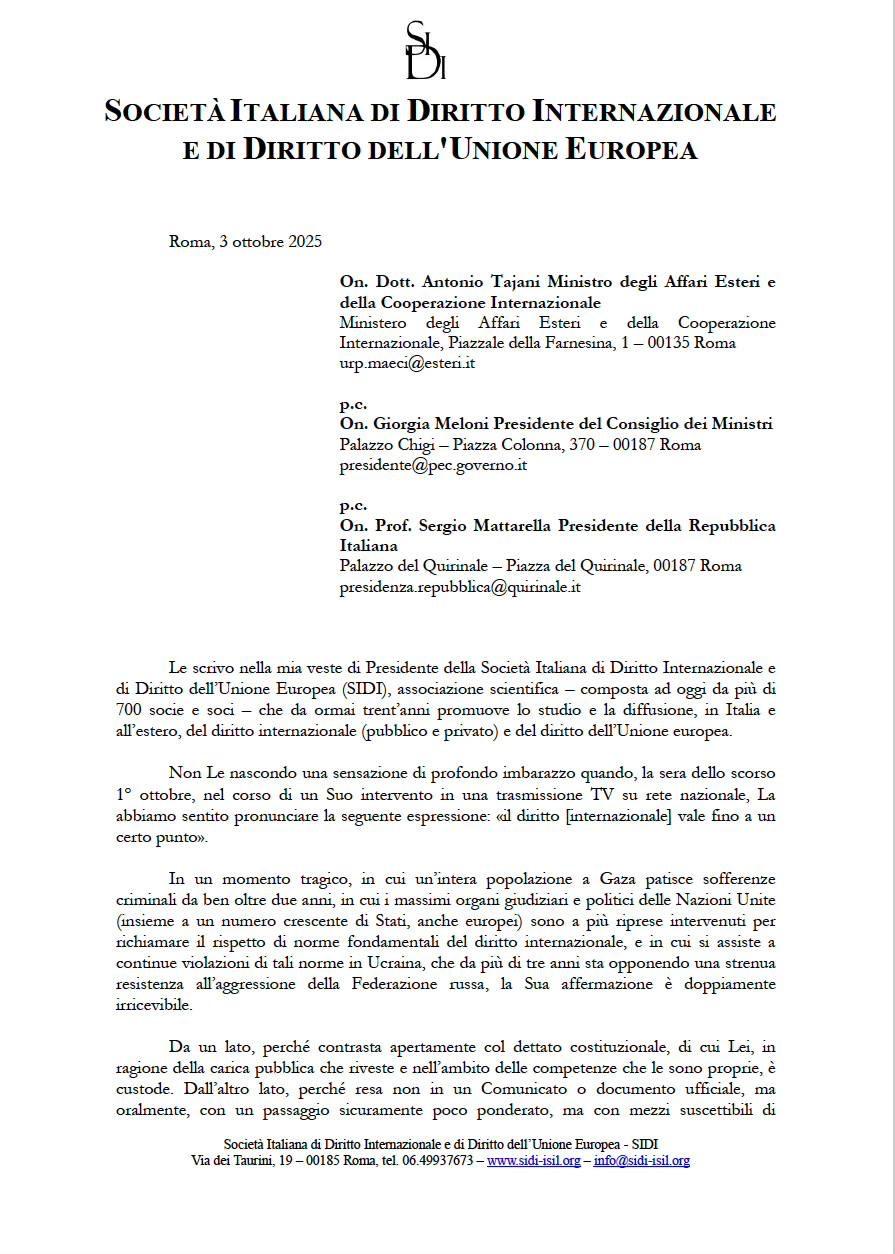
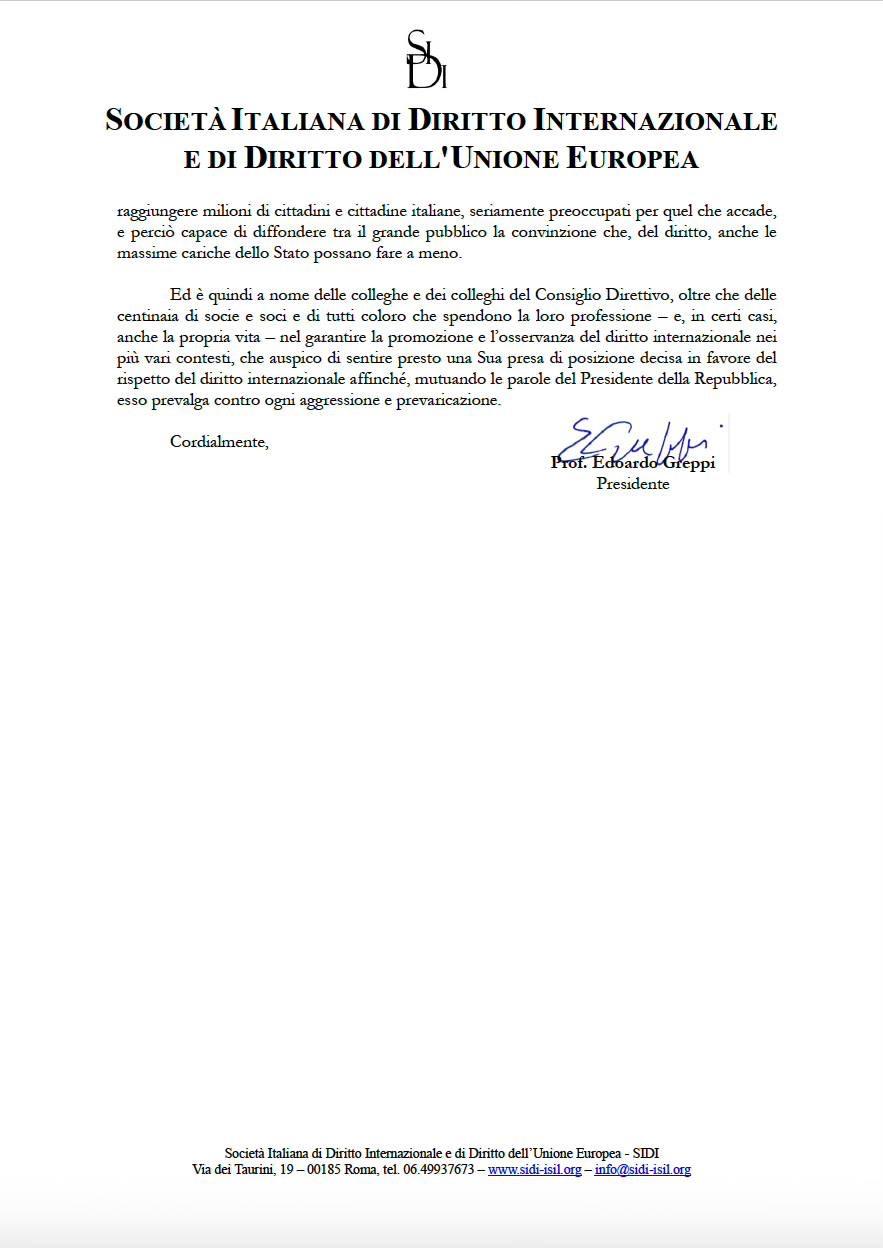
La reazione della SIDI, come quella — contestuale — dell’Unione delle Camere Penali Italiane, non è frutto di accademismo né di formalismo giuridico. È un atto di resistenza. Un baluardo contro la progressiva erosione di una cultura del limite e della responsabilità, di cui il diritto internazionale è espressione vitale. Lo dimostra il caso della Global Sumud Flotilla, intercettata dalla Marina israeliana in acque internazionali, al di fuori di ogni legittimo quadro giuridico.
I membri degli equipaggi — tra cui cittadini italiani — sono stati detenuti arbitrariamente, in aperta violazione delle norme sul transito marittimo e sulla protezione delle missioni umanitarie. Non è stato un errore tattico: è stata una violazione deliberata dei principi di necessità, proporzionalità e distinzione, che costituiscono il nucleo duro del diritto internazionale umanitario. Di fronte a tali azioni, la diplomazia italiana avrebbe dovuto pretendere risposte chiare, rapide, intransigenti. Invece, tace o balbetta, mentre il Ministro competente nega la vincolatività stessa del quadro normativo internazionale.
I due episodi — l’esternazione politica e l’atto militare extraterritoriale — si saldano in una stessa traiettoria pericolosa: la progressiva decomposizione dell’ordine giuridico internazionale. Una decomposizione che procede su due binari: da un lato, la riduzione del diritto a strumento d’occasione, malleabile e negoziabile a seconda del contesto; dall’altro, la prassi della forza che si auto-legittima attraverso il silenzio dei garanti e l’inerzia delle istituzioni. Il rischio non è più teorico. È strutturale. Ogni cedimento, ogni formula ambigua, ogni dichiarazione irresponsabile genera precedenti, e ogni precedente apre un varco: alla legittimazione dell’eccezione, all’assuefazione all’illegalità, alla disintegrazione della norma. Serve, dunque, una risposta netta, non dilazionabile, articolata su tre livelli.
Il Governo italiano deve riaffermare, con chiarezza, che la politica estera del Paese si fonda sul rispetto pieno, sostanziale e operativo del diritto internazionale. Le istituzioni europee e multilaterali devono uscire dall’ambiguità e assumere con fermezza la funzione di sorveglianza attiva e di reazione concreta contro le violazioni dei trattati e delle convenzioni.
La società civile giuridicamente avvertita — avvocati, magistrati, docenti, operatori del diritto — deve smettere di considerare queste derive come inevitabili, o peggio, irrilevanti. Il silenzio della competenza è complicità. Il diritto internazionale non è una decorazione diplomatica. È ciò che tiene unito il mondo civile, l’unico argine rimasto contro l’anarchia geopolitica. È la condizione di esistenza delle minoranze, dei civili, dei rifugiati, dei prigionieri, dei senza voce.
Sostenere che «vale fino a un certo punto» significa legittimare ogni sopruso, ogni crimine, ogni occupazione, ogni bombardamento fuori legge. Significa affermare che la forza può prevalere sulla norma, che l’arbitrio può sostituire la giustizia. Significa, in ultima analisi, tradire lo spirito dell’articolo 10 della Costituzione italiana, che vincola l’ordinamento interno al rispetto delle norme internazionali generalmente riconosciute. In Ucraina, a Gaza, nel Mar Mediterraneo o nei corridoi diplomatici di Bruxelles e New York, il diritto non è un’opzione. È una linea rossa.
Chi rappresenta uno Stato democratico ha il dovere di difenderla, non di cancellarla con un sorriso in diretta TV.