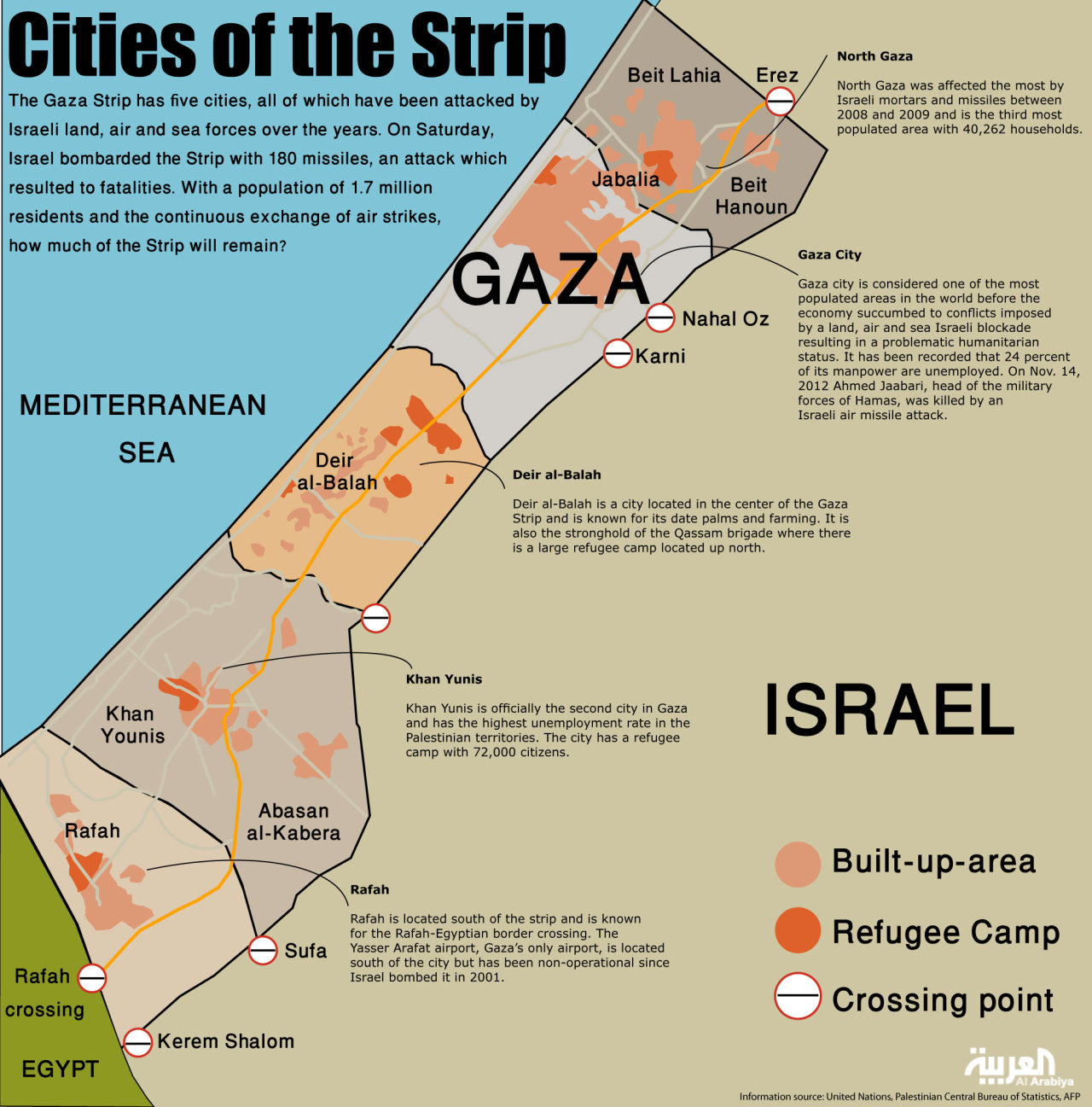L’annuncio della partenza, prevista per il 31 agosto 2025, di una nuova missione marina promossa dalla Freedom Flotilla Coalition, su Gaza, ha riaperto una ferita geopolitica nel Mediterraneo orientale.
di Cristina Di Silvio
Gaza, il dramma continua, il mondo tace
Decine di imbarcazioni, sostenute da reti civili in 44 paesi e guidate da attivisti esperti, partiranno da porti come la Spagna e Tunisi con un obiettivo chiaro e inquietante: rompere il blocco israeliano su Gaza, consegnare aiuti essenziali e scuotere l’opinione pubblica mondiale.
Tra i naviganti figura Greta Thunberg, già espulsa in giugno dopo il sequestro della nave Madleen da parte di forze israeliane.
Questa coalizione si proclama espressione di disobbedienza civile non violenta, ma il nodo centrale sta nel suo impatto concreto sul diritto internazionale, sul diritto umanitario e sulla sicurezza marittima nella zona. Nei mesi trascorsi, le azioni precedenti hanno mostrato un quadro operativo al limite della legalità.
Il 2 maggio 2025, la nave Conscience è stata attaccata in acque internazionali al largo di Malta da due droni, provocando incendi, danni allo scafo e al sistema elettrico, senza vittime, ma causando lesioni lievi a bordo.
La Freedom Flotilla ha attribuito la responsabilità dello strike a Israele, che però non si è esposto, mentre Malta ha negato di aver impedito l’ingresso della nave, affermando che l’equipaggio aveva rifiutato l’ispezione, pur offrendo assistenza tecnica e logistica, e disegnando un quadro di tensione fra sicurezza nazionale e obblighi umanitari.
A luglio la Handala, salpata da Siracusa con 21 attivisti da una dozzina di paesi e carichi di aiuti umanitari, è stata fermata in acque internazionali circa 40 miglia da Gaza, sequestrata con modalità violente, telecamere oscurate e comunicazioni interrotte, e infine condotta al porto di Ashdod, dove gli attivisti sono stati trattenuti o deportati. Questi atti violano chiaramente il diritto internazionale: l’UNCLOS garantisce la libertà di navigazione in alto mare (articoli 87 e 90) e vieta l’uso della forza contro imbarcazioni civili; la Carta delle Nazioni Unite, all’articolo 2(4), proibisce la minaccia o l’impiego della forza internazionale non autorizzata; la Quarta Convenzione di Ginevra impone protezione ai civili e vieta punizioni collettive; infine, la Corte Internazionale di Giustizia ha emesso ordini vincolanti per facilitare l’accesso umanitario a Gaza.
La missione prevista per settembre non è un viaggio umanitario isolato: è una provocazione politica deliberata, una sfida netta alle regole operative imposte unilateralmente da Israele nelle acque di Gaza. Questa volta la partecipazione di figure globali accresce la pressione mediatica e diplomatica. Ma la domanda cruciale resta sul piano militare e legale: qual è la qualifica giuridica dei partecipanti?
Qual è la legittimità dell’uso della forza per fermare una nave disarmata e senza armamenti?
E soprattutto: cosa accade al diritto internazionale quando uno Stato esercita un’autorità d’eccezione permanente?
In definitiva, la Freedom Flotilla è oggi una forma di pressione non convenzionale, sospesa tra intervento umanitario e attivismo politico. Nell’impiegare mezzi militari contro civili disarmati, Israele rischia di compromettere ulteriormente la propria posizione nel contesto globale. La comunità internazionale, senza una risposta coordinata, alimenta l’erosione di norme già fragili in un mondo segnato da conflitti asimmetrici.
La vera sfida emerge non solo sul mare, ma nella capacità del diritto internazionale di restare baluardo tra sicurezza e diritti umani. Se non emergono meccanismi efficaci di responsabilità, il Mediterraneo rischia di rimanere una zona grigia, dove legalità, deterrenza e abuso si confondono in un pericoloso compromesso.