Quando l’autodifesa diventa punizione e la giustizia un campo di battaglia: Gaza, metafora del non diritto.
di Cristina Di Silvio
Gaza, cronaca di una supremazia militare ma non strategica
C’è un momento in cui il diritto smette di essere un apparato tecnico e si trasforma in materia politica viva.
Un momento in cui le sue regole, la sua grammatica, i suoi strumenti di delimitazione della violenza cessano di essere neutri e iniziano a incrinarsi sotto il peso della realtà.
La guerra in corso nella Striscia di Gaza, a quasi due anni dall’attacco del 7 ottobre 2023, rappresenta con ogni evidenza uno di questi momenti di rottura sistemica. Quello che si consuma oggi a Gaza non è solo l’ennesimo conflitto asimmetrico a sfondo territoriale e ideologico: è un caso di studio globale sulla crisi irreversibile del diritto internazionale come strumento regolatore dei conflitti armati.
A dirlo, in modo netto, non sono organizzazioni militanti, né ONG umanitarie.
Lo affermano, nero su bianco, due autorevoli dichiarazioni accademiche, distinte ma convergenti. La prima, sottoscritta da decine di professori di diritto delle principali università israeliane, è un appello che rappresenta una frattura interna senza precedenti nel sistema giuridico accademico israeliano.
La seconda proviene dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP), massima autorità scientifica in materia penale in ambito italiano.
Entrambe denunciano, con il rigore della disciplina giuridica e la lucidità dell’analisi, la trasformazione della guerra a Gaza in una campagna punitiva incompatibile con i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario.
Il nodo centrale, sollevato da entrambe le dichiarazioni, ruota attorno alla differenza tra autodifesa legittima e uso sproporzionato della forza. I docenti israeliani non negano il trauma del 7 ottobre: l’offensiva coordinata da Hamas — con incursioni armate, stragi di civili, presa di ostaggi e diffusione mediatica della violenza — ha rappresentato un attacco deliberato e brutale contro lo Stato di Israele, il più grave degli ultimi decenni.
Tuttavia, è proprio a partire da questa ferita collettiva che i giuristi ricordano una verità basilare: il diritto alla difesa, per quanto riconosciuto dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, non è né illimitato né incondizionato.
Ogni azione armata dev’essere conforme ai principi di necessità, proporzionalità e distinzione tra obiettivi militari e civili.
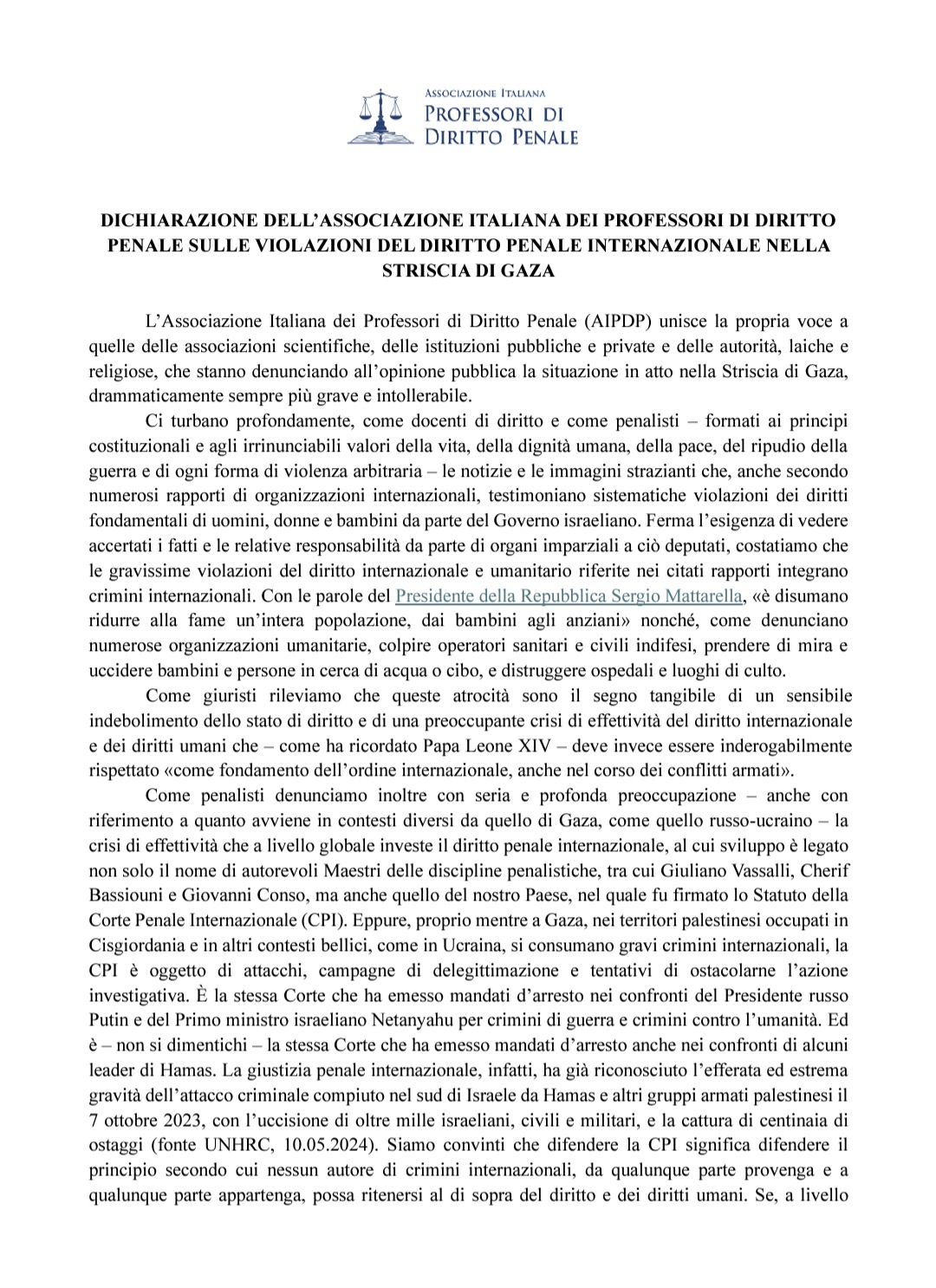
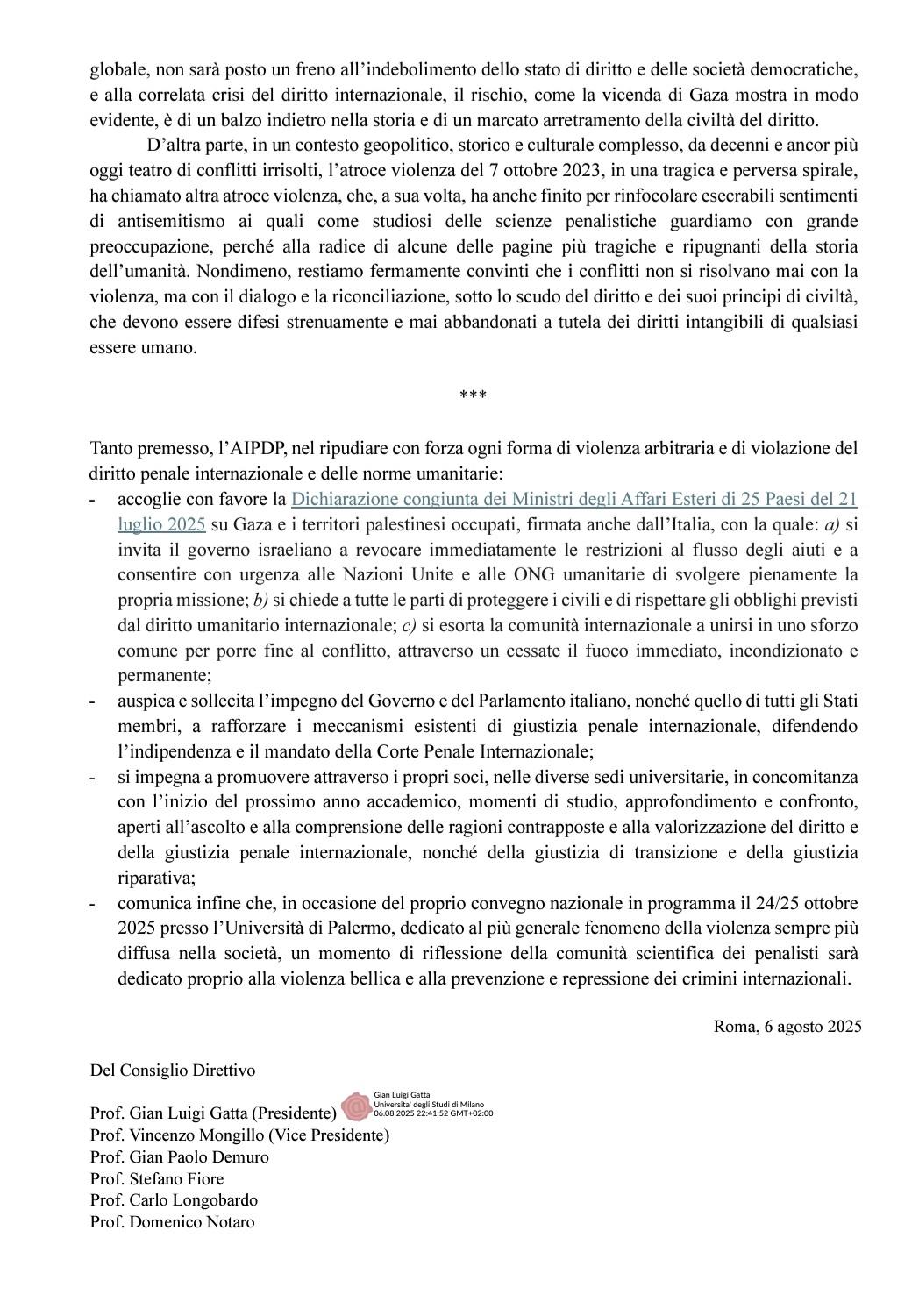
A quasi due anni dall’avvio dell’operazione Spade di Ferro (Swords of Iron), l’azione militare israeliana appare, secondo gli accademici, ormai priva delle condizioni che giustificano un uso legittimo della forza. Hamas è stato in gran parte disarticolato sul piano operativo, le sue strutture logistiche devastate, la capacità di comando fortemente compromessa.
Il numero di ostaggi ancora detenuti è limitato, frammentato e vittima di dinamiche di negoziato complesse. Ma nel frattempo, la popolazione civile di Gaza è sprofondata in una crisi umanitaria totale, con distruzione capillare delle infrastrutture sanitarie, scolastiche e residenziali, scarsità estrema di acqua potabile e un tasso di malnutrizione infantile drammaticamente crescente.
L’azione militare, dunque, non è più configurabile come autodifesa.
È rappresaglia.
È punizione collettiva.
È una forma di annientamento strategico che mette a rischio la legittimità dello Stato che la conduce, generando effetti controproducenti sia sul piano operativo che su quello geopolitico.
Sul fronte italiano, l’AIPDP ha scelto un linguaggio diretto e privo di ambiguità.
Le distruzioni indiscriminate, l’uso della fame come arma, il targeting sistematico di obiettivi civili, l’uso di armamenti ad alto potenziale in aree densamente popolate, le decine di migliaia di vittime civili — tra cui, secondo le Nazioni Unite, oltre 15.000 bambini — costituiscono, secondo l’Associazione, violazioni manifeste del diritto penale internazionale: in particolare, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, così come codificati dallo Statuto di Roma e dalle Convenzioni di Ginevra.
Ma l’elemento più inquietante non è soltanto giuridico. È istituzionale e sistemico.
In gioco non c’è solo la sorte della popolazione palestinese, ma la tenuta dell’intera architettura giuridica internazionale costruita dopo il 1945: quella che, in teoria, dovrebbe vincolare anche gli Stati più potenti, anche nelle condizioni di massima tensione bellica.
La prova più lampante della crisi è la reazione della comunità internazionale ai mandati di arresto della Corte Penale Internazionale.
Quando la CPI ha incriminato Vladimir Putin, i governi occidentali hanno applaudito l’atto come una riaffermazione del diritto.
Quando, nel maggio 2024, la Corte ha emesso mandati contro Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant e i vertici di Hamas, l’intero impianto di sostegno al diritto internazionale si è incrinato.
La reazione è stata durissima: minacce di sanzioni ai giudici, pressioni politiche, delegittimazione dell’organo giurisdizionale, fino alla proposta statunitense (mai formalizzata) di tagliare i fondi alla Corte. La frattura è ormai evidente: il diritto vale finché non tocca gli alleati.
La giustizia internazionale è universale solo in teoria, selettiva nella pratica.
Un diritto così non è più credibile. E la sua crisi investe direttamente la legittimità dell’Occidente come promotore di un ordine basato su norme condivise.
Il momento di maggiore impatto giuridico e politico è arrivato il 19 luglio 2024, con l’opinione consultiva della Corte Internazionale di Giustizia che ha dichiarato illegale l’occupazione israeliana dei Territori Palestinesi.
La sentenza — fondata su un’analisi ampia di fonti internazionali, norme consuetudinarie e trattati multilaterali — qualifica le pratiche di insediamento, demolizione, blocco e annessione de facto come violazioni gravi del diritto internazionale, imponendo a tutti gli Stati l’obbligo di non riconoscere né sostenere in alcun modo l’occupazione.
Questa impunità ha un costo.
Disintegra la fiducia nelle istituzioni internazionali. Erode il fondamento morale e giuridico delle democrazie liberali.
Crea un vuoto normativo che viene rapidamente occupato da attori autoritari, cinici, pronti a usare l’assenza del diritto come leva di potere. Alimenta l’instabilità regionale, il riarmo, il reclutamento terroristico.
Produce effetti collaterali devastanti anche nei contesti occidentali: aumento dell’antisemitismo, polarizzazione sociale, delegittimazione dell’idea stessa di giustizia internazionale.
Gaza, oggi, non è solo una catastrofe umanitaria: è una crisi strutturale dell’ordine giuridico globale.
Un test critico per l’intero sistema multilaterale. Una soglia oltre la quale le parole “diritto”, “pace”, “difesa” e “guerra giusta” rischiano di perdere ogni significato, Concludo ora il testo con una chiusura all’altezza dell’impianto analitico e tematico dell’articolo, mantenendo il tono solenne, rigoroso e strategicamente orientato alla riflessione sul futuro dell’ordine globale.
Il limite tra forza legittima e violenza arbitraria non è solo una questione giuridica: è un discrimine politico, etico e militare. Superarlo significa non solo violare norme, ma minare le fondamenta stesse della convivenza internazionale.
Per gli apparati militari, questo rappresenta un punto di svolta operativo: l’impiego della forza al di fuori delle regole mina la legittimità strategica dell’intervento, amplifica il risentimento delle popolazioni, favorisce l’insorgenza armata, produce danni a lungo termine che nessuna vittoria tattica può compensare.
La guerra moderna non si gioca solo sul terreno, ma anche sul piano della percezione, della legittimità e della compatibilità con l’ordine normativo internazionale.
Per le democrazie occidentali, Gaza è un banco di prova.
È il momento in cui devono decidere se difendere l’universalità del diritto — anche quando è scomodo, anche quando colpisce un alleato — o accettare un mondo dove la forza, ancora una volta, prevale sulle regole.
Se la risposta resta ambigua, Gaza non sarà solo un luogo di morte, sarà il simbolo della fine del diritto. Il punto in cui la giustizia ha smesso di essere un riferimento condiviso per tornare a essere, semplicemente, una variabile del potere.
In un mondo così, nessuno sarà più veramente al sicuro, perché se il diritto non protegge i più vulnerabili, alla lunga non potrà proteggere nessuno.